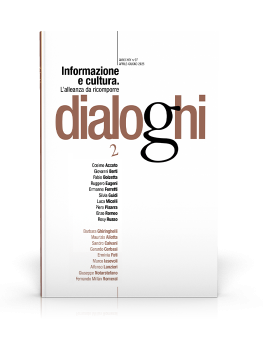Dalla periferia del mondo, Francesco ha aperto cantieri di Vangelo e fraternità. Una Chiesa povera, sinodale, dialogante, capace di abitare le ferite della storia con lo stile della prossimità e del discernimento. Un cammino aperto, nella forza dello Spirito.
L’ avvicendamento al soglio pontificio è avvenuto nel tempo di Pasqua, tempo liturgico in cui la Chiesa tutta è invitata a contemplare la vita vera che non finisce, il segno del sepolcro vuoto e della pietra spalancata. Il tempo in cui, insieme a tutta la comunità dei discepoli, siamo chiamati ad accogliere il dono della Pace che viene dal Signore Risorto.
Colpisce molto che sia la pace a fare da trait-d’union da Francesco a Leone XIV: il desiderio di annunciare al mondo che c’è un’alternativa alla spirale della guerra e della violenza, alla cultura della prevaricazione e dello scarto, alla strumentalizzazione delle persone e allo sfregio alla loro dignità, soprattutto dei più piccoli e dei più poveri.
Guardiamo a questo tempo come ad un dono che riceviamo con semplicità e stupore, una sorpresa dello Spirito che ci colma di gioia e di gratitudine. Ed è proprio questo il sentimento che prevale sugli altri nel fare memoria del pontificato di Francesco che ha varcato (e superato) un decennio caratterizzato dalla poli-crisi, iniziato con gli effetti destabilizzanti delle crisi finanziarie della fine del primo decennio del secolo che avevano innescato un ripensamento complessivo delle istituzioni economiche sino al deflagrare della “guerra mondiale a pezzi” che segna la fine del multilateralismo e la tragica riabilitazione della guerra come strumento per affrontare i conflitti. Una stagione che lo stesso pontefice ci aveva insegnato a leggere come un cambiamento di epoca.
La consapevolezza di un mutamento radicale globale, geopolitico climatico e antropologico, scuote l’impalcatura culturale elaborata nel confronto con la secolarizzazione e la spinge ad un aggiornamento a lungo tenacemente perseguito dal papa “venuto dalla f ine del mondo”. Una visione che chiede di andare oltre “la fine della storia” per elaborare nuove visioni, non da soli ma insieme, ponendo maggiore attenzione alle nuove sfide che emergono nella linea ermeneutica della esculturazione1. Una provocazione per il mondo occidentale e in particolare europeo, succube dei suoi rimpianti e di nostalgie che spesso affannano senza energie le proposte pastorali, ma anche per le spinte populiste e nazionaliste che hanno espresso in questi anni una risposta sbagliata ad un tema che meritava un supplemento di coraggiosa riflessione e che Francesco aveva identificato come globalizzazione dell’indifferenza.
Ritengo che occorra partire da tale angolatura per comprendere la scelta di iniziare il pontificato con un viaggio a Lampedusa, nel cuore del Mediterraneo diventato «il più grande cimitero d’Europa»2 e di proseguire con gesti importanti come l’apertura della Porta Santa nel Giubileo straordinario della Misericordia da lui indetto nel 2015 a Bangui, nel cuore del Centrafrica, centro di conflitti e di guerre divenuto, con tale gesto, capitale spirituale per tutto il mondo. E poi scrive la prima enciclica sociale su un tema profondamente francescano ma anche di grande attualità che anticipa di qualche mese l’Agenda 2030 degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, proponendo il paradigma dell’ecologia integrale che indica non solo un framework integrato tra obiettivi economici sociali e ambientali, ma rilancia una visione arricchita dello sviluppo umano integrale che fu già di Paolo VI.
Nel 2019, qualche mese prima del dilagare della pandemia del Covid-19, sottoscrive insieme al Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb il Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune, al quale segue la seconda enciclica sociale Fratelli tutti: nel primo, i due sottoscrittori parlano insieme di valori perenni necessari per una architettura di pace come la giustizia, la misericordia, il dialogo e la cultura della tolleranza; nella seconda, al capitolo ottavo, Francesco rilancia un tema caro al suo predecessore come il ruolo delle religioni e della fede nello spazio pubblico e il dialogo tra esse come condizione necessaria nella ricerca della pace.
Lo scoppio della guerra in Ucraina, unitamente alla recrudescenza dello scontro tra Israele ed Hamas con l’apertura di un fronte cruento di massacro di innocenti a Gaza, tormenta il cuore di Francesco.
La sua è una «dolorosa coscienza»3 verso tutte le vittime innocenti soprattutto civili, bambini e anziani che lo porta continuamente a implorare il cessate il fuoco e la ripresa delle trattative sino all’ultima lettera durante la sua ultima degenza al Policlinico Gemelli, appuntamento a lungo rinviato per portare a termine un calendario fitto di incontri, ufficiali e non, di viaggi apostolici e visite inattese e programmate. Mette così a fuoco meglio quella angolatura con la quale ha iniziato a osservare e amare questo mondo e questo tempo: «La fragilità umana, infatti, ha il potere di renderci più lucidi», scrive il Santo Padre rivolgendosi così a tutti noi attraverso il direttore del «Corriere della Sera». «Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra. C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità». La complessità che caratterizza il cambiamento d’epoca esige il ritrovamento di una cultura comunitaria che è possibile riconoscere nella profezia della sinodalità, che papa Francesco indica come chiave per ripensare il processo di riforma che la Chiesa deve intraprendere.
Pensando a questi anni ci viene però subito in mente la prospettiva della Chiesa in uscita, testimone della gioia del Vangelo che si trasmette attraverso uno stile popolare di amicizia e condivisione quotidiana, che diventa prossimità con “tutti, tutti, tutti”, e che è alla ricerca di una fraternità più grande attraverso il dialogo ospitale e disponibile con l’altro. Papa Francesco ha spinto con coraggio e decisione tutta la Chiesa a immergersi in quella prospettiva conciliare che il suo predecessore, da lui stesso elevato agli onori degli altari, Paolo VI, descrive in Ecclesiam suam: «La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio» (67). Ed è proprio su questo stile di conversazione che inaugura e dà forma al processo sinodale a ogni livello e lo struttura come un percorso di ascolto permanente e profondo delle vite, della vita, della storia. Un ascolto che attiva uno sguardo contemplativo delle vicende umane, che permette di generare una simpatia drammatica con esse: è sempre quella dolorosa coscienza che ci connette spiritualmente e interiormente alla realtà, per vivere un discernimento che ci guida all’azione. Una riconsegna dell’attitudine conciliare della lettura dei segni dei tempi, che provoca il ritualismo neo-pelagiano e l’astrattezza neo-gnostica, verso cui Francesco, in diversi modi, ci ha messi in guardia, identificandoli anche come ostacoli nel cammino verso la santificazione delle coscienze che è meta fondamentale della vita cristiana.
Missionarietà e sinodalità si intrecciano per promuovere quell’improrogabile rinnovamento ecclesiale e quella conversione pastorale che è l’anima del percorso di riforma sinodale.
L’assunzione di uno stile permanente di ascolto reciproco, profondo, autentico che si lascia sorprendere e interrogare dalle contraddizioni della storia e dai drammi dell’esistenza senza farsi schiacciare, senza cedere alla disperazione della solitudine, della tristezza individualista.
La Chiesa “sognata” da papa Bergoglio, sin dalla scelta del nome, è una chiesa povera per i poveri, tensione evangelica che il pontef ice ha assunto interpretando innanzitutto uno stile di sobrietà e costruendo il suo magistero grazie a una interpolazione di gesti e di attenzioni che hanno avuto il merito di andare oltre i confini ecclesiali, dilatandoli al mondo intero.
Riconosciamo così il senso profondo del cammino sinodale, itinerario non astratto né autoreferenziale, che può aiutare la comunità cristiana nella sua globalità a ritrovare quella postura di ascolto e accoglienza per abitare il pluralismo che provoca la comunione ecclesiale.
L’annuncio del Vangelo, fine essenziale della comunità cristiana, ha un ineludibile contenuto sociale, che custodisce nel suo cuore la vita comunitaria e il senso di una prossimità generosa e gratuita. Il processo sinodale prende così forma di nuovo processo istituente affidato al popolo di Dio che, in costante e fiducioso ascolto dello Spirito, impara a riconoscere e ad affrontare la sfida epocale di elaborare una forma credibile della Speranza cristiana (Pt 3,15).
Molti i cantieri aperti durante tale processo che costituiscono ancora sfide poste di fronte al “santo pellegrinaggio” del popolo di Dio, convocato da Francesco a un inedito e articolato esercizio di corresponsabilità. Esercizio che sta progredendo nella misura della sua capacità di maturare una nuova consapevolezza spirituale di fronte alle domande e ai drammi che attraversano le singole esistenze e la storia attuale dell’umanità, travagliata da un tumultuoso e vorticoso dinamismo spinto da un altrettanto sorprendente progresso scientifico e tecnologico.
Attenzione però alla sua pretesa di dominio, spesso sostenuta da una razionalità calcolante e da meccanismi selettivi tanto efficienti quanto spietati: il Papa ci ha messo in guardia dal rischio del paradigma tecnocratico, dalla logica degli algoritmi privi di coscienza e un’economia che uccide dimenticando l’uomo e il suo bisogno di senso.
Nella sua ultima enciclica, il papa gesuita ha affrontato con determinazione proprio il tema della disumanizzazione in atto, invitando tutti a “ritornare al cuore”, a ritrovare il tempo e lo spazio per una vita interiore che è il luogo di sintesi più appropriato per ricomporre la frammentazione e la disgregazione che un certo approccio scientifico-specialistico e tecnocratico tentano di fare dell’esistenza umana: «Il nucleo di ogni essere umano, il suo centro più intimo, non è il nucleo dell’anima ma dell’intera persona nella sua identità unica, che è di anima e corpo. Tutto è unificato nel cuore, che può essere la sede dell’amore con tutte le sue componenti spirituali, psichiche e anche fisiche»4. È un invito a fidarsi dell’uomo e della sua capacità di bene, nonostante le tante evidenze di infedeltà e tradimento, di fratricidio e violenza, di barbarie e accaparramento che non sono mai mancate in ogni epoca storica, come ci mostra il grande racconto biblico.
È un invito a fidarsi di quelle relazioni buone di cura che chiedono una nuova fantasia creativa, un’«organizzazione della Speranza»5 in tempi tristi.
Abbiamo letto e ascoltato in queste settimane molti commenti a margine del pontificato di papa Jorge Mario Bergoglio, argentino figlio di emigrati italiani, prima chimico poi membro della Compagnia di Gesù, divenuto Vescovo di Roma, svolgendo il suo ministero di pontefice per la prima volta con la presenza silenziosa di un papa emerito. Si è rivolto all’umanità con un saluto amichevole e con un sorriso cordiale, tratti semplici che gli hanno permesso di parlare con tutti. La sua immediatezza e sobrietà hanno generato entusiasmo e apprezzamento per uno stile di Chiesa che depone le insegne del potere e prende parte alla vita delle donne e degli uomini nell’umile gesto del servizio. Le sue parole e i suoi gesti sono stati una boccata di aria fresca per molti, soprattutto per quanti avevano intrapreso con entusiasmo e passione la via di rinnovamento conciliare e che si sono sentiti incoraggiati a proseguire e ad andare avanti fiduciosi, guidati dallo Spirito Santo che sempre illumina il cammino della sua Chiesa e che non manca di sorprenderla, come ha fatto, ancora una volta, con l’elezione di papa Leone XIV.
Note
1 Ci si riferisce in particolare a J. de Kesel, Cristiani in un mondo che non lo è +. La fede nella società moderna, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2023.
2 Francesco, Discorso al Parlamento Europeo, 25.11.2014.
3 Francesco, Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della Casa comune, 24.05.2025,
4 19. Id., Lettera enciclica Dilexit nos sull’Amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo, 24.10.2024, 21.
5 L’espressione, come è noto, è di don Tonino Bello, utilizzata spesso anche da papa Francesco, ad esempio in occasione del messaggio di saluto ai partecipanti alla XLIX Settimana Sociale dei cattolici italiani a Taranto.